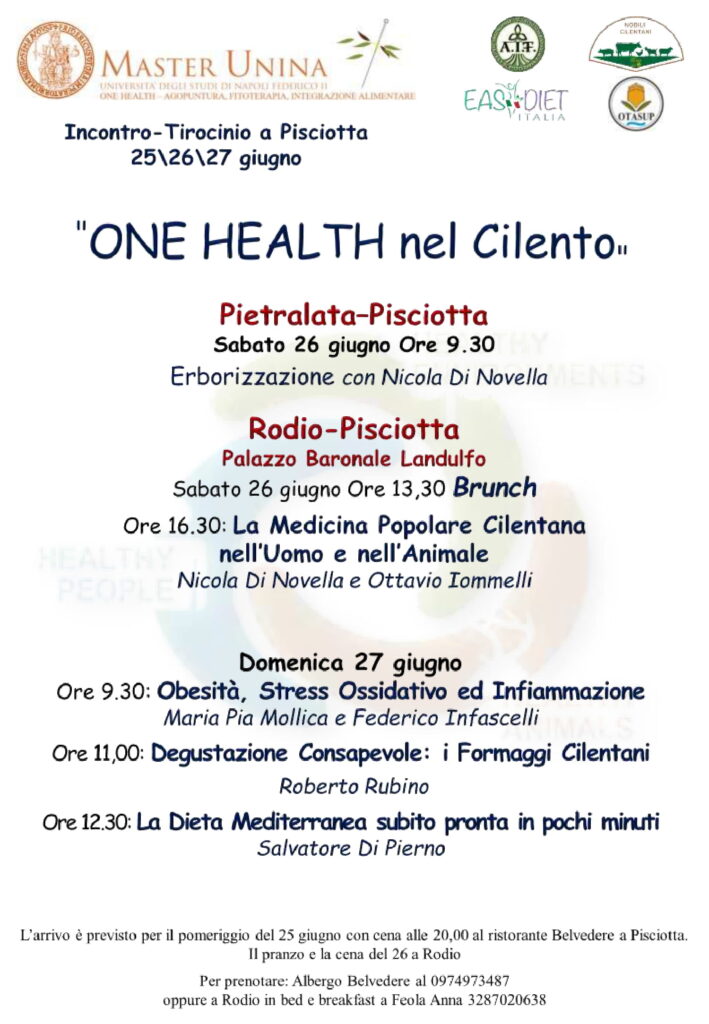
Blog
MANIFESTO PER RIABITARE L’ITALIA
RIPRISTINIAMO LA FESTA DEL MAIALE
In Pisciotta è ancora forte l’attrazione per la Festa del Maiale, che è anche occasione di rafforzamento del vincolo di partecipazione alla comunità.
Si tratta di una tradizione che va scomparendo a causa delle trasformazioni imposte all’agricoltura dalle regole liberistiche sui consumi.
Intendiamo riprendere la pratica dell’agricoltura a misura d’uomo, che, per chi vuole leggere in positivo la lezione che la natura ha dato espandendo l’epidemia in tutto il pianeta, può diventare occasione di sviluppo per le comunità emarginate e di miglioramento della qualità della vita.
Vogliamo quindi che venga ripristinato l’allevamento dei maiali neri da parte dei contadini, secondo regole nutrizionali che perseguano l’eccellenza del prodotto, attraverso il rispetto di tutte le normative sanitarie e fiscali.
Il Maiale Nero, che oggi è ritenuto un privilegio per la qualità della sua carne, era qui conosciuto fin dal tempo dei Romani.
Promoviamo, perciò, la costituzione di una associazione alla quale possono partecipare tutte le persone che, in qualunque parte del mondo risiedano, vogliono partecipare all’iniziativa, fosse anche solo per godere della partecipazione alle feste.
Abbiamo già programmato una serie di incontri, il primo dei quali sarà dedicato alle “lucaniche” apprezzate dai Romani, e sarà tenuto appena le regole per l’emergenza sanitaria lo permetteranno.
Invitiamo tutte le persone che apprezzano l’iniziativa a manifestare la loro adesione, inviando una lettera all’Osservatorio, anche via mail, dando suggerimenti e consigli.
Il Presidente
Avv. Lorenzo Sacchi
Pisciotta e lo sviluppo umano: la crisi della pianificazione urbanistica e le possibili soluzioni.
Una persona di buona volontà che volesse pensare a vie possibili per riabitare Pisciotta dopo la inevitabile pandemia, deve necessariamente esaminare la crisi in cui è sprofondata la pianificazione urbanistica che fu avviata dalla legge regionale n. 16 del 2004 la quale impose ai Comuni di completare la pianificazione entro un termine che è stato via via prorogato fino al 31.12.2020.
Come tutti sanno questa situazione è stata determinata dalla politica dominante la quale quando, in data 17.2.2019, ricevette dal MIBACT la proposta di norme prescrittive per il vincolo D. M. 8.11.1968 sulla conca di Pisciotta e sugli ulivi pisciottani pensò che nel paese fosse caduta una disgrazia e si affrettò ad adottare, con la delibera n. 18 in data 11.3.2019, un puc nel quale pensò di affermare che la pianificazione urbanistica, di competenza del Comune, dovesse prevalere sulla pianificazione paesaggistica che, ai sensi dell’art. 117 Cost., appartiene allo Stato.
Come tutti sanno la attuale legge regionale prevede che il PUC adottato venga approvato dal Consiglio Comunale ma tutti (compresa la Giunta di Pisciotta) sanno anche che secondo quanto prescrive l’art. 3 c. 4 del Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5 del 4.8.2011 la Giunta per poter presentare il PUC al Consiglio deve chiedere alla Provincia una dichiarazione di coerenza del piano urbanistico comunale alle strategie a scala sovracomunale, individuate anche in riferimento al piano territoriale di coordinamento provinciale.
La Giunta infatti chiese il rilascio di tale dichiarazione di coerenza ma la Provincia di Salerno con nota del 29.9.2020 comunicò la improcedibilità del subprocedimento attivato, proprio perché il Comune non aveva “conformato” il suo strumento di pianificazione urbanistica alla prescrizione della proposta inviata dal MIBACT in data 17.2.2019, come prescrive il Codice dei Beni Culturali.
A quell’epoca il Comune avrebbe potuto annullare il puc del 2018 e avviare, anche sollecitando le necessarie partecipazioni popolari, un nuovo puc conformato alla norma prescrittiva inviata dal MIBACT (nel frattempo divenuto D. M. 1150 del 17.10.2019).
Ma la politica oggi conosce vie traverse e il Sindaco comunicò alla Stampa che il provvedimento negativo sarebbe stato superato perché aveva approntato presso la Provincia un tavolo sul quale sarebbe stata “riesaminata” la documentazione già inviata a suo tempo e ritenuta improcedibile.
Infatti in data 23.11.2020 il Sindaco inviò una lettera alla Provincia e successivamente la Giunta ha adottato la delibera n. 98 del 18.12.2020 con la quale ha indicato “gli elaborati di recepimento delle prescrizioni cogenti del decreto MIBACT n. 1150/2019”.
In data 4.1.2021 la Provincia ha inviato al Comune una comunicazione nella quale non fa alcun riferimento alla delibera n. 98 e invece informa il Comune che l’ultima legge regionale (n. 38 del 29.12.2020) ha stabilito che
“i Comuni approvano il preliminare di piano di cui al Regolamento 4.8.2011 n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021; gli stessi adottano il PUC entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e lo approvano entro il termine perentorio del 31.12.2021”.
Da ultimo il Ministero, con nota inviata al Comune in data 19.1.2021 rispondendo a una nota inviata dall’associazione “Una Mano per Pisciotta”, ha chiesto al Comune di Pisciotta di attenersi alle regolamentazioni imposte dai citati decreti ministeriali, e ha invitato il Comune a “inviare formalmente il contenuto del PUC nella sua interezza così come adeguato alle norme d’uso contenute nel D. M. n. 1150 del 17.10.2019 all’interno del PUC stesso, relativamente a tutte le sue parti, che non constano della sola tavola sopracitata).
Il Comune, con nota del 26.1.2021 firmata dal RUP non ha inviato al Ministero quanto richiesto dalla sopracitata nota ma ha inviato solo la nota con la quale aveva inviato la copia della delibera di adozione n. 18 dell’11.3.2019 e la copia della delibera n. 25/2020 che erano state inviate alla Provincia quando aveva richiesto il rilascio della dichiarazione di coerenza e la Provincia aveva emesso la dichiarazione di improcedibilità del sub-procedimento per la dichiarazione di coerenza; e non ha inviato proprio la delibera n. 98 nonostante che la stessa fosse stata esplicitamente richiesta dal Ministero con esplicito invito a rimetterla alla Sovrintendenza perchè esprimesse le sue valutazioni: con tale atteggiamento il Comune ha confermato che la delibera n. 98 è stata confezionata ad uso e consumo dei frequentatori del tavolo che il Sindaco dice di aver apparecchiato presso la Provincia.
Si tratta della ennesima arrogante violazione del “principio di leale collaborazione” che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 240 del 17.11.2020) deve essere rispettato nei rapporti tra lo Stato e gli Enti locali in funzione di un interesse di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio.
Tra l’altro è evidente che la Giunta Comunale cerca di tenere segreto e nascosto il tavolo apparecchiato presso la Provincia ma l’intervento di Mibact del 19.1.2021 ha unificato il procedimento per cui è impensabile che la Provincia possa prestare attenzione alla delibera n. 98 se la stessa non viene sottoposta alla Sovrintendenza di Salerno e questa non certifichi che il Comune ha rispettato le prescrizioni di pianificazione paesistico-territoriale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 141 bis, c. 3 e 140 c. 2 del D.lgs. 42/04.
Anche la lettera della Provincia del 4.1.2021, emanata dopo la trasmissione alla stessa della famosa delibera 98, costituisce una chiara attestazione sul fatto che il Comune di Pisciotta non può percorrere più la via tracciata dalla legislazione regionale per la pianificazione urbanistica ma deve poter utilizzare, se vuole evitare il commissario, la via tracciata dalla legge regionale n. 39;
Sul punto pare di poter dire che la politica dominante non ha alcun interesse ad intraprendere la nuova via, dato che questa non consentirebbe mai di assicurare l’ampio assalto edificatorio che aveva unito tutte le forze politiche che adottarono il PUC n. 18/2019.
Così stando le cose, la persona di buona volontà deve affrontare il problema della mancanza di un puc, che alla cittadinanza deve interessare perché, come ha recentemente ricordato il Consiglio di Stato (IV 1.6.2018 n. 3316) “il potere di pianificazione urbanistica del territorio, costituzionalmente confermato ex art. 117, 3 c. Cost. alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e il cui esercizio è normalmente attribuito al Comune, non è limitato alla individuazione delle zone del territorio comunale, ma deve essere inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico sociali della comunità locale”.
A questo proposito, è necessario ribadire che il puc adottato l’11.3.2019, le cui finalità economico – sociale sono state spiegate dal Sindaco in una intervista alla Stampa e consistevano nell’assimilare Pisciotta alla condizione adottata da Ascea e da Palinuro, non ha programmato un utilizzo delle aree per zone ma ha attribuito capacità edificatorie nella parte che avrebbe dovuto dedicare alla individuazione delle zone a singoli fondi, individuati catastalmente dai nominativi dei proprietari: si tratta di un modo di procedere che accende la politica solo sul punto della elargizione edificatoria e produce divisioni insanabili nella comunità locale, addirittura nelle famiglie.
E perciò le persone di buona volontà devono affrontare il problema della mancanza del PUC, come “mancanza della disciplina dell’utilizzo delle aree per realizzare finalità economico sociale della comunità locale” e, per noi, dello sviluppo umano di Pisciotta.
Allo stato, occorre immaginare lo scenario che si produrrà nel campo dell’urbanistica regionale quando verrà a scadere alla fine di quest’anno il termine stabilito dalla legge 39 del 2020, perché la Regione è tenuta a nominare il Commissario, scegliendolo nell’elenco che ha già formato.
Nell’elenco vi sono avvocati e ingegneri, i quali avranno i poteri che in campo urbanistico ora appartengono al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.
Nel campo dell’urbanistica il Commissario dovrà necessariamente dare incarico di redigere il puc a un “urbanista”.
In questo modo può però venire a costituirsi un potere che può anche deragliare e perciò le persone di buona volontà devono organizzarsi promuovendo associazioni e comitati a protezione degli interessi dei pisciottani, individuati anche con riferimento a singole parti del territorio (un borgo, una sorgente, un bene archeologico da valorizzare, un casale vecchio, una campagna particolare etc).
In questo modo le associazioni e i comitati avranno la forza di interloquire con il nominato Commissario per imporre le soluzioni dei pisciottani e per togliere spazio agli ambasciatori del malaffare che sempre più spesso hanno le chiavi della politica.
In questa ottica, le persone di buona volontà devono esaminare la possibilità di ricorrere al MIBACT, che nel Servizio 5 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha costituito un manipolo di urbanisti che sono quelli che formularono la proposta di vestizione del vincolo inviato al Comune in data 17.2.2019 e che ha salvato la costa dalla programmata aggressione.
E su questo, mi auguro, la discussione sia la più ampia possibile.
Avv. Domenico Parrella
La nostra terra
Premessa
Forse non tutti sanno che Marco Tullio Cicerone, scrittore romano, filosofo ed uomo politico, vissuto tra il 106 ed il 43 a.C., trascorreva le sue vacanze nel Cilento. Poco prima di essere ucciso dai sicari di Antonio, scrisse a Caio Trebazio Testa, valente avvocato di Elea (la moderna Velia nel Comune di Ascea), una bella lettera, in cui gli chiedeva notizie del figlio:
“O uomo divino, cosa ne è del tuo giovane figlio tanto educato e tanto avido di apprendere? Continua a seguire con la consueta diligenza i corsi di grammatica e di retorica? Si appassiona sempre alla musica ed al teatro? Seguilo con cura, amico mio, nei vostri giovani è riposta l’unica vostra risorsa contro i tiranni ed i barbari “
Ed ancora :
“Quanto mi sarebbero di giovamento le passeggiate per i boschi lussureggianti e lungo la spiaggia che da Porta Marina giunge al Porto; quanto piacere avrei dalle discussioni nelle quali siamo soliti indugiare con gli amici all’ombra della Porta Rosa o ai piedi del Tempio di Atena “.
Quindi già nel passato la natura, le spiagge, i boschi del Cilento e del Vallo di Diano, erano conosciuti dal mondo della cultura. Voglio prendere spunto da questa missiva per fare un escursus tra gli aspetti storico-naturalistici di questo territorio, che oggi viene a costituire il “PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO” e che la’associazione AIFF (associazione italiana di fitoterapia e fitofarmacologia) ha eletto sin dal 1997 sua sede spirituale. Un’area naturalistica della Campania, in assoluto tra le più belle d’Italia, che offre grande accoglienza a coloro, che della natura si servono per curare nella mente e nel corpo i propri e gli altrui malanni.
Il Cilento ed il Vallo di Diano hanno suscitato, in questi ultimi tempi, l’interesse culturale di tutto il mondo. Il riconoscimento ufficiale da parte dell’UNESCO è strettamente connesso alla profondità delle radici storiche ed alla complessità dei processi biologici e geomorfologici, che ne hanno determinato le progressive strutturazioni. Uno straordinario patrimonio di reperti documentano, dal Paleolitico all’età dei metalli, le prime direttrici dell’antropizzazione cilentana e del Vallo di Diano : dalla ” Grotta delle Ossa ” di Marina di Camerota (500.000 anni fa) a quelle di Pertosa e di Castelcivita ( 60.000 anni fa). Nonostante la varietà geografica e le variazioni climatiche e microclimatiche, che si sono susseguite, la presenza dell’uomo è stata pressocchè continua e viene attestata da un gran numero di grotte e ripari, riferibili alle principali culture preistoriche dei cacciatori neandertaliani. Nel Neolitico inizia a delinearsi l’organizzazione antropica con l’edificazione del paesaggio culturale. Il Cilento diventa luogo di contatto per gli scambi marittimi tra Costa tirrenica e Mediterraneo occidentale, mentre, verso est, la lunga depressione del Vallo di Diano, ricca di ambienti palustri e di attraversamenti fluviali, costringe i traffici verso le alture. L’uomo comincia a padroneggiare i luoghi elevati, costruendo ricoveri e sacralizzando gli spazi e, così, nei percorsi vengono seguite le linee dei crinali, che ancora oggi troviamo segnati da antichi tratturi, da santuari e da edicole votive. Il successo del modello economico pastorale, durante l’età del bronzo e del ferro, porta alla creazione della cosiddetta “società appenninica” e, quindi, i nuclei dei pastori, che stanziano sulle rive del fiume Sele, iniziano a sviluppare le attività di transumanza delle greggi dalla costa verso le zone collinari e montane dell’entroterra. Culture mediterranee, costa cilentana e genti appenniniche si intrecciano tra di loro e, alla luce di questi traffici, si giustificano le tracce della civiltà micenea ritrovate nel 1996 nella “Grotta del Pino” di Sassano ( circa 1800 anni a.C.). Fenici e Greci portano il ferro nel Cilento, che diventa area di frontiera ed anello di contaminazione tra Tirreno e Ionio, con la direttiva Sele-Tanagro-Agri-Sinni, e tra Nord-Sud, con il percorso Etruria-Paestum-Elea. Il Vallo di Diano si trasforma in centro di collegamento tra Etruria, Campania e Lucania. Alla fine del VII sec. a. C. il fiume Sele segna il confine tra colonizzazione greca e mondo etrusco, ma non rappresenta una barriera economica e culturale, tanto che l’insediamento indigeno di Poseidonia, l’odierna Paestum, diventa area privilegiata di scambio, sacralizzata dalla presenza del Tempio di Hera, divinità tutelare dei giardini e dei raccolti. Nel 540 a.C. viene fondata con finalità strategiche e commerciali la città di Elea. Essa, però, si trasforma subito nella città culturale più importante della Magna Grecia; la scuola filosofica fondata da Senofane, precursore del “monoteismo”, viene resa più celebre dal pensiero “dell’Essere e del Non Essere” di Parmenide e dalla dialettica del suo discepolo Zenone. Elea diventa subito punto di riferimento e di studio per tutto il Mediterraneo. Elea è anche sede di un Collegio di Medici e di una Scuola di Medicina, ritenuta da molti la progenitrice della Scuola Medica Salernitana ; le sue Terme (ancora oggi uno degli edifici meglio conservati) sono meta di infermi e punto di riferimento di chi cerca risposte ai propri malanni. Nel frattempo, modi e costumi greci giungono nel Vallo di Diano lungo l’antica rete dei crinali montani ed i “Re – pastori Lucani” li adottano e li rivivono attraverso le passioni e la cultura dei guerrieri. A partire dalla fine del V sec. a. C. incomincia la conquista diretta del territorio di Poseidonia da parte dei Popoli Lucani, i quali, dopo piccoli ed insignificanti scontri, effettuano una penetrazione pacifica, senza compromettere la prosperità delle campagne. In seguito sulla egemonia lucana, che si allarga dallo Ionio al Tirreno, si innesca un periodo di benessere ed un incremento demografico. Si accentuano i fenomeni di urbanizzazione nei vecchi centri e se ne creano di nuovi come Atena Lucana, Padula, Teggiano, Sanza, Roscigno, Rocca Gloriosa e Omignano. Le campagne cominciano a popolarsi, nuovi terreni vengono dissodati, la coltivazione della vite viene ad accompagnarsi a quella dell’ulivo ed il manto forestale originario viene a ridursi. Sembra che io stia parlando di oggi. Infatti, a distanza di 2500 anni, mi rendo conto che nulla o poco è cambiato nel paesaggio agrario e nella rotazione delle colture. Il periodo di unità e di articolazione territoriale tra costa tirrenica e costa ionica viene interrotto dalla conquista romana. I tracciati viari romani, con la realizzazione di ponti per l’attraversamento dei fiumi e di opere di bonifica delle aree paludose, relegano in secondo piano i tratturi e le zone interne; il Vallo di Diano, con Cosilinum e Marcellianum, e la Val d’Agri, con Grumentum, divengono un attraversamento importante Nord-Sud ed Est-Ovest, mentre il Cilento vede i suoi centri perdere d’importanza strategica. Cade l’Impero Romano sotto i colpi dei Goti e solo verso il 536 d.C., con la venuta di Belisario, generale al servizio di Giustiniano, questa parte dell’Italia meridionale acquista con i Bizantini un nuovo assetto socio-economico, ma di breve durata. Difatti, l’invasione da parte dei Longobardi nel 568 e la nascita del Ducato di Benevento determinano una sorta di sbarramento tra il blocco bizantino settentrionale e quello meridionale; la gente ritorna sui monti e, sugli antichi crinali, sorgono castelli, fortezze, conventi e chiese: ritorna la trama organizzativa pre-romana. I Longobardi, ponendo l’attenzione più verso le Province del nord, lasciano il sud ancora alla cultura bizantina, ma verso l’ anno 829, accortisi che gli Arabi stanno occupando alcuni territori in Sicilia, in Calabria ed in Campania, operano con Basilio I una sistematica riconquista di queste Terre. Il monachesimo basiliano comincia a segnare il territorio del Cilento e del Vallo di Diano e diventa la pietra fondante di numerosi piccoli centri, che vanno a costituire una vasta rete di casali, facendo assumere al territorio l’attuale conformazione geopolitica.
Nel secondo millennio dell’era cristiana Normanni, Svevi, Aragonesi, Saraceni, Angioini e Borboni, lasciano importanti e numerose tracce nel Cilento costiero ed in alcuni centri dell’interno come Padula e Teggiano e riconoscono alle genti dell’Antica Lucania Occidentale la loro intelligenza, il loro valore, la loro laboriosità ed il grande attaccamento alla loro terra. Le popolazioni del Cilento e del Vallo di Diano hanno anche scritto splendide pagine di storia in difesa della libertà e dei diritti inalienabili dell’individuo, dal gesto di Zenone contro il tiranno Nearco all’innalzamento dell’Albero della Libertà nella Piazza di Vallo della Lucania e di Montesano sulla Marcellana. Solo la monarchia francese dei Savoia, vestendo gli abiti apparenti di una Italia Unita, ci ha chiamato “popolo di briganti”! Forse perchè un popolo, fiero delle sue origini e della sua cultura, combatte per essere indipendente? Ma si sa, la storia la scrivono i vincitori…
E noi stiamo cercando di scrivere qualche parola del primo capitolo della storia del terzo millennio. Il Vallo di Diano ed il Cilento occupano tutta la parte meridionale della provincia di Salerno, al punto d’incontro tra Regione Campania e Regione Basilicata e rappresentano per intero il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, voluto dalla legge quadro del 6 dicembre 1991. Oggi è riconosciuto dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. È un paesaggio vivente, crocevia millenario di popoli e civiltà, un sistema complesso di terre, natura, cultura, biotipi e monumenti, caratterizzato dall’equilibrata ed armonica fusione uomo-ambiente, prodottasi nel tempo e giunta fino a noi per rivelarsi e farsi rispettare da tutti. I suoi 181.000 ettari, i 290.000 abitanti, gli 80 Comuni, le 8 Comunità Montane, la rilevanza del patrimonio culturale e la ricchezza del paesaggio lo collocano, come area protetta, ai primi posti in Europa.
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è un territorio ancora in evoluzione dove le esigenze storiche si sono incrociate con quelle economiche, sociali, artistiche e naturali. Le stesse attività agricole, legate ancora molto alla tradizione, non solo hanno conservato le potenzialità biologiche in termini di biodiversità, ma, al contrario, hanno determinato contesti agro-forestali unici in tutta la fascia appenninica. Il Parco Nazionale rappresenta la prima pietra dell’edificio della nuova storia del Vallo di Diano e del Cilento e dipenderà molto da noi abitanti, se questa costruzione sarà bella o brutta, se si riempirà di azioni, attività e cultura o rimarrà vuota, e se sarà ancora luogo di incontro tra mare e montagna, tra Occidente e Oriente, tra culture nordiche e culture africane.
Il Paesaggio e la sua Natura.
Per le loro particolari caratteristiche climatiche e geomorfologiche i territori del Cilento e del Vallo di Diano sono siti di interesse eccezionale dal punto di vista fisico-vegetazionale e naturalistico. La geomorfologia è caratterizzata da rilievi montuosi, digradanti verso il mare. La costa è formata da una successione di falesie, spiagge, insenature e promontori, interessati da fenomeni carsici e ricchi di grotte marine e sorgenti di acqua dolce. Essa è frutto delle zolle tettoniche, con cui l’orientamento generale del massiccio appenninico si combina a fenomeni orogenetici contrastanti e dà luogo a rilievi di diversa litologia e disposti irregolarmente, separati da vallette trasversali e longitudinali. Ad ovest del Vallo di Diano, i massicci della parte orientale sono formati da calcari dolomitici e raggiungono le altitudini più elevate con i Monti Alburni (1742 m), il Monte Motola (1700 m) ed il Monte Cervati (1898 m), cima più alta della Campania. Lunghe incisioni, doline, inghiottitoi, grotte, sorgenti, forre, tavolati e valli strette e profonde caratterizzano questo paesaggio.
I rilievi verso la costa, pure essi calcarei, sono costituiti da rocce sedimentarie di differenti origini, costituite da argille, arenarie, marnie e conglomerati, formando il flysch del Cilento e le cime del Monte Stella (1131 m), del Gelbison o Monte Sacro (1702 m) e del Monte Bulgheria (1225 m). A causa delle particolari condizioni geomorfologiche, della posizione geografica e delle peculiarità climatiche il territorio del Parco è caratterizzato da una ricchezza eccezionale di ambienti naturali, ai quali è associato un elevato grado di varietà biologica, provata dall’esistenza di circa 1900 specie vegetali tra erbacee e legnose e circa 320 vertebrati, di cui l’80% uccelli. Molti mammiferi appenninici sono presenti e tra essi voglio ricordare il cinghiale, il lupo, la volpe, il tasso, e, nei fiumi, la lontra e la nutria. Volendo fare un’analisi un pò più dettagliata della vegetazione, suddivido il territorio in tre macro-aree:
* la costa
* le aree interne
* il settore sub-montano e montano.
Lungo le rupi e le falesie della costa, in ambienti resi estremi dalle deposizioni saline,dominano particolari comunità di “alofite” (piante che prediligono aria ricca di sali),mentre nelle zone basse e sabbiose vegetano le ammofile. A ridosso di questo habitat, con i cisti, comincia a svilupparsi la macchia mediterranea con le piante sempreverdi, come il mirto, il lentisco, il rosmarino, le querce da sughero, il carrubo, il leccio. Le prime chiome delle roverelle, querce grandi a foglie caduche, rappresentano la congiunzione con la flora delle aree interne, caratterizzata da boscaglia mista, castagneti, cerreti e carpineti, che per il passato hanno sostenuto la misera economia dei luoghi. La fascia sub-montana e quella montana vengono dominate dai faggi, tra i quali si insediano altre specie arboree come gli aceri, i sorbi selvatici, gli ontani, i tassi; in alcuni habitat particolari troviamo gli abeti bianchi, residui dell’antica copertura appenninica e le betulle pendule, relitti del fenomeno delle glaciazioni. Molte sono le piante endemiche, caratteristiche del luogo, tra le quali brillano, per la loro unicità mondiale, la Genista cilentina e la Primula palinuri, simbolo del Parco Nazionale.
L’Antica Lucania è lieta di ospitare OTASUP (“Osservatorio Pisciotta”) con tutta la sua natura e la sua cultura, dall’attualità del pensiero parmenideo alla saggezza del vecchio contadino analfabeta, dal Tempio di Poseidone alle pietre più umili di un ovile diruto, dagli spettacolari tramonti di Palinuro al buio delle forre e delle grotte degli Alburni, dal suono dei versi degli aedi erranti alle cantilene di fede nei santuari tra i monti, dalla grande Porta Rosa di Velia alle capanne dei carbonai nelle faggete, dai portali medievali di Teggiano ai tetti di segale dei ricoveri pastorali. E’ un luogo che riesce a comunicare l’uomo nella sua interezza e ciò è importante in un’epoca in cui il tecnicismo virtuale imperante fa ritenere l’umanesimo un cadavere da incenerire. Eppure, già 2.500 anni fa, Diogene, con il suo lanternino, era alla ricerca dell’uomo perduto!
Spero che questi brevi appunti siano riusciti a dare un’immagine viva e bella della nostra terra; se non c’è l’ho fatta c’è una sola soluzione: seguitemi e vi condurrò su tutti i sentieri dei 181.000 ettari del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Nicola Di Novella
